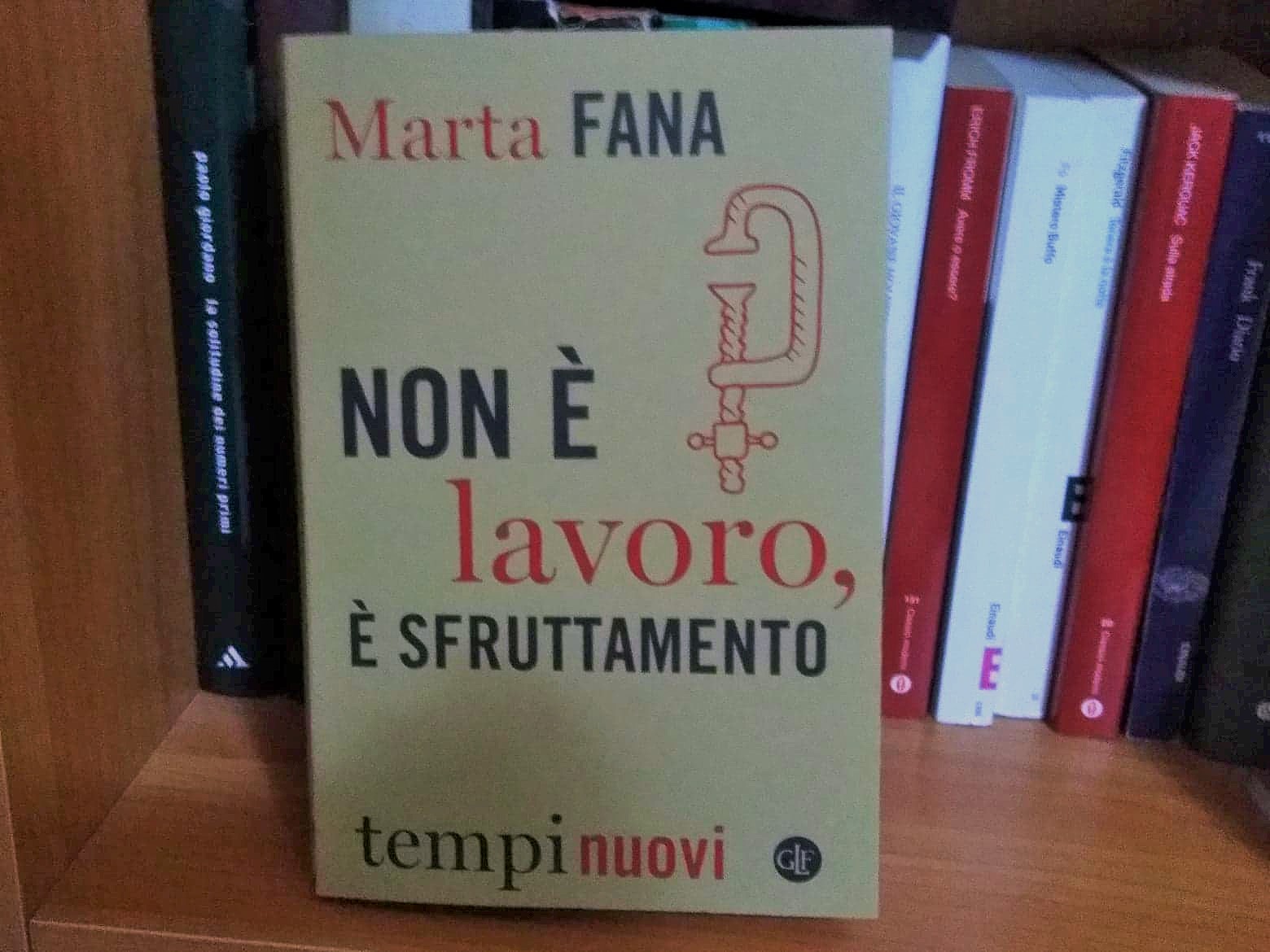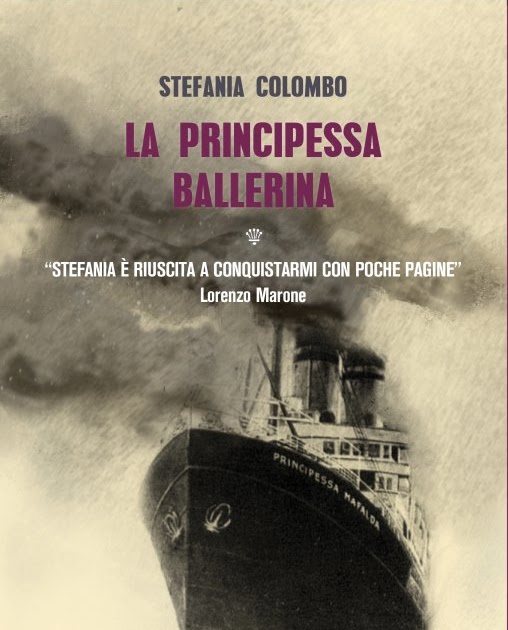Di Marta Fana mi parlò per la prima volta mio fratello, esperto di finanza. Mi disse: <<Sai, c’è una ricercatrice in scienze economiche che afferma molte cose simili al tuo filosofare. È dalla parte dei lavoratori, dei precari, degli sfruttati>>.
La vidi poco tempo dopo in tv, ospite nel programma Carta bianca. Lo scontro in diretta tra lei e Oscar Farinetti, patron di Eataly, divenne poi virale sul web. Lampante la divergenza di opinione: da una parte la boria di Farinetti, l’aggressività di chi comanda senza scrupoli, di chi sciorina dati non sempre veritieri. Dall’altra, la tranquillità di chi controbatte senza paura, dati alla mano, di chi zittisce il superbo capitalista, al quale non importa se gli inquadramenti del personale non siano a norma, ma che si vanta di aver creato qualcosa di unico e di dare posti di lavoro ad 800 euro. Pure troppo per la povera gente, no? Le minacce di querela nei confronti di Marta Fana a fine intervento non poterono che far aumentare la stima nei suoi confronti. Ad ottobre 2017 è uscito il suo libro-inchiesta: Non è lavoro, è sfruttamento, edito da Laterza.
Il libro si apre con le parole di un ragazzo suicida, arrivato al gesto estremo simbolo di frustrazione e della precarietà lavorativa. “Io non ho tradito, io mi sento tradito”. Una frase che suona come una condanna. Scrive Fana nel prologo: “C’è più di una generazione a cui avevano detto che sarebbe bastato il merito e l’impegno per essere felici. Quella di chi si è affacciato al mondo del lavoro cresciuto a pane e ipocrite promesse, e quella di chi si affaccia oggi, quando la promessa assume il volto di un’ipocrisia manifesta. Oggi ci si suicida perchè derubati di possibilità, di diritti, di una vita libera e dignitosa. Qualcosa è andato storto e c’è chi continua a soffirare sul fuoco delle responsabilità individuali, delle frustrazioni che la solitudine sociale produce. Di precariato si muore. E non è un caso. Il precariato è la risposta feroce contro la classe lavoratrice […] Il potere di sfruttare , di dileggiare tutti quelli che contribuiscono a creare le fortune dei pochi che se le accaparrano”. Nonostante i dati e i termini tecnici, i libro è assolutamente fruibile e comprensibile anche a chi non abbia dimestichezza con il mondo economico. Sì, quello dei contratti, delle manovre finanziare, quello che compare nei titoli dei tg, nelle bagarre al senato e alla camera, negli articoli di giornale che noi leggiamo distrattamente. Tagli, tasse, precarizzazione. Ci vogliono flessibili, open minded, senza problemi, con esperienza pregressa anche se hai trascorso anni e anni sui banchi di scuola, extroverted, no choosy, no bamboccioni, propositivi, senza pensieri. Ci vogliono pronti ad ogni sacrificio, quelli delle generazioni precedenti che hanno ipotecato il nostro futuro. Quello di Marta Fana è un viaggio negli inferi: “Il dilagare del lavoro povero, spesso gratuito, la totale assenza di tutele e stabilità lavorativa sono fenomeni all’ordine del giorno, che si abbattono su più di una generazione, costretta a lavorare di più ma a guadagnare sempre di meno, nonostante viviamo in una società il cui potenziale produttivo già permetterebbe di ridurre e distribuire il tempo di lavoro mantenendo e/o raggiungendo un tenore di vita più che dignitoso. È la realtà contro cui si infrange la narrazione dominante sulla Generazione Erasmus e sui Millennials, la stessa che con facilità dichiara che coloro che sono nati negli anni ’80 dovranno lavorare fino a 75 anni per avere una misera pensione. […] Il furto quotidiano operato a danno dei lavoratori, di oggi e di domani, è stato sostenuto dall’ideologia del merito, imposta per mascherare un inevitabile conflitto tra chi sfrutta e chi è sfruttato. Ma soprattutto per negare la matrice collettiva dei rapporti di lavoro, dei rapporti di forza in gioco: è la retorica per cui ognuno è artefice del proprio destino.”
Parole dure e chiare. Colpisce l’attenzione immediata della ricercatrice verso chi non ha nulla, chi sopravvive con un solo stipendio e ai risvolti psicologici drammatici della carenza di lavoro e dello sfruttamento. È una strage di stato, silenziosa, pervasiva, nascosta dietro nomi altisonanti e esterofili di manovre, contratti, statistiche. Ci si sente impotenti, colpevoli senza alcuna colpa, difetto sociale, in una società sempre più instabile, in cui ogni tendenza eversiva e di ribellione viene bollata come attacco al sistema, assorbita e silenziata nel minor tempo possibile. Nel cinquantesimo anniversario del ’68, sarebbe utile ricordare come l’emergenza della deriva della società capitalistica fosse stata descritta e annunciata da uno dei filosofi più importanti dello scorso secolo, Herbert Marcuse. I suoi testi Eros e Civiltà (1955) e L’uomo a una dimensione (1964) sembrano ispirare, con il tentativo di sintesi freudo-marxista il pensiero e le pratiche del ’68. I segnali preoccupanti degli effetti della proliferazione smodata delle merci, dei beni di consumo, l’uso nocivo della tecnologia per l’ambiente, il crollo dei principi democratici, i disagio delle classi più povere, il fronte unito del capitalismo e il suo totalitarismo al di là delle frontiere, dei muri e delle nazioni, i focolai di guerra in tutto il mondo, l’aggressività umana, la sottomissione alla realtà e ai poteri forti: tutto ciò viene analizzato e studiato da Marcuse. Perché l’uomo è sottomesso? Perché non si ribella? Da dove nasce il senso di dominio? Il senso di colpa perenne? Perché la mancanza di libertà è accettata silenziosamente? È possibile un’esistenza alternativa? Marcuse arriva a delineare nuove forme di repressione e nuove configurazioni del principio di realtà. La repressione addizionale, ovvero le restrizioni rese necessarie dal potere sociale e il principio di prestazione: la forma storica prevalente del principio di realtà.
Se già Marx ed Engels negli anni 1848-50 avevano dimostrato come la borghesia non fosse più in grado politicamente di portare a termine la rivoluzione, nel ’68 la decadenza della borghesia, la debolezza e la crisi del proletariato erano un fattore oggettivo. Marcuse non smetterà mai di professare il suo amore per la vita e affermò che la vita umana è degna di essere vissuta e che si debbano creare le condizioni per renderla tale. Però, l’uso selvaggio della tecnologia, in quegli anni di esperimenti atomici e bellici, lo sfruttamento della natura, la sottomissione degli operai e del proletariato, stavano facendo scivolare l’umanità in un baratro senza fine, creando nuovi disagi psichici nell’uomo occidentale. La libertà diventa sicurezza, pertanto negazione della libertà di parola e di pensiero, ergo di critica. La manipolazione dei bisogni da parte di interessi costituiti crea effetti totalitari, un benessere diffuso e una società infelice. Chi soffre maggiormente in questo processo alienante ed automatizzante? Ovviamente i lavoratori, gli operai. L’uomo, nella società industriale avanzata, diventa particella della catena di montaggio; la sua coscienza felice, ad una dimensione, vive del circolo perverso tra manipolazione e bisogno. Potenzialmente si possono soddisfare tutti i desideri, perdendo così autonomia politica e di pensiero, creando false illusioni di pace e di benessere. L’individuo può rompere questo giogo? Può cambiare il mondo, i suoi valori, lo status quo? Perché perpetrare così tanto dolore? Come disse Marcuse durante una sua visita a Parigi: “Gli studenti non si sono rivoltati contro una società povera e male organizzata, bensì contro una società ricchissima, organizzatissima nel suo lusso e nel suo spreco, mentre il 25% della popolazione vive nella povertà e nei ghetti. La rivolta non è diretta contro i danni che questa civiltà provoca, ma contro i suoi benefici. È’ un fenomeno della società opulenta.” Il filosofo, soprattutto nella fase post ’68, sottolineò nei suoi scritti la necessità di un ripensamento urgente del ruolo della classe operaia alla luce della trasformazione del lavoro, intravedendo una disintegrazione del proletariato, incitando ad una maggiore alleanza con gli studenti e i meno abbienti.
Qualche anno dopo,Deleuze e Guattari con il loro L’Anti Edipo, capitalismo e schizofrenia (1972) sembrano confermare la schizofrenia insita nel capitalismo analizzata dal pensatore tedesco . Il capitale denaro è un punto di follia giunto all’ultimo stadio. La loro anti psichiatria smaschera il malfunzionamento della macchina psicoanalitica e i suoi schemi prefissati, affermando però che le linee di fuga e le rivoluzioni sono la speranza per uscire da un sistema malato. In un’intervista concessa alla rivista francese Actuel alla domanda : << Voi associate la schizofrenia al capitalismo; questo è il fondo del vostro libro. Ci sono casi di schizofrenia in qualche altro tipo di società?>> Guattari risponde: <<La schizofrenia è inscindibile dal sistema capitalistico […] Ogni sistema ha, d’altra parte, la sua malattia particolare: l’isterismo nelle società primitive, le manie depressive-paranoiche nei grandi imperi…L’economia capitalista parte dalla decodificazione e dalla deterritorializzazione; ha i suoi mali estremi […] ma ha anche le sue estreme conseguenze, le rivoluzioni>>. C’è dunque uno spiraglio utopico, nel senso positivo del termine, in senso blochiano, inteso cone nicht jetz il non ancora e non il niemals, mai. Testi e dichiarazioni che non hanno perso affatto la loro attualità.
In appendice al libro-inchiesta vi è una lettera dell’autrice indirizzata all’allora ministro Poletti, in cui manifesta tutto il disgusto per le sue dichiarazioni e l’operato del governo. La guerra dei vaucher, nuova forma di schiavitù, l’abolizione dell’articolo 18. Le conseguenze delle scelte scellerate di questi anni, le falle del sistema pesano sulle vite dei più deboli, di chi non può o non è riuscito a cambiare vita. Il capitalismo senza rispetto per l’essere umano, avente come solo ed unico obiettivo il profitto, ha portato ad un disagio senza pari. La crisi economica del 2007, l’adozione di misure di austerity hanno ridotto sul lastrico milioni di persone, bloccato la mobilità sociale, causando gravi problemi psicologici ( si parla di ben 164 milioni di malati psichici in Europa, con un aggravamento considerevole negli ultimi anni ) rinnovando la divisione in classi. Marta Fana, voce libera e indipendente, chiude il libro auspicando il ritorno di una lotta reale, concreta, per “ribaltare” lo stato di cose presenti. L’umanità è avviata su un cammino senza ritorno. Occorre ripensare la sfera pubblica, bloccare una precarietà indotta, smettere di subire silenziosamente. Ricordare e attuare il senso della prassi marxiana, espresso ne le Tesi su Feuerbach (1845), prassi capace di cambiare la realtà sociale, poiché è l’uomo che educa e modifica l’ambiente.
Non è lavoro, è sfruttamento è un libro necessario perché senza ipocrisia alcuna, bensì con rabbia e lucidità, racconta la realtà e il nostro mesto tempo.Ci fa sentire inadeguati, mortificati, “violentati”, avvizziti, arrabbiati. È tempo di ristabilire i diritti della working class, degli studenti. È tempo di resistere e lottare. Rifiutare la mercificazione dei corpi, delle menti, l’idea di un progresso a senso unico, inarrestabile e per questo ingiusto e cupo. Creare e condividere cultura. Disobbedire e ribellarsi ai soprusi, alle gabbie sociali, mentali, quelle della depressione, della sofferenza, della nevrosi, per dare spazio al possibile, all’utopia che ancora ci tiene in vita. Fermare la guerra tra i più deboli, unirsi per riscoprire la dignità del lavoro e celebrare la bellezza della vita. Non sarà facile, ma forse è l’ultima speranza che abbiamo.
"Se leggo un libro che mi gela tutta, così che nessun fuoco possa scaldarmi, so che è poesia. Se mi sento fisicamente come se mi scoperchiassero la testa, so che quella è poesia. È l'unico modo che ho di conoscerla. Ce ne sono altri?" E. Dickinson